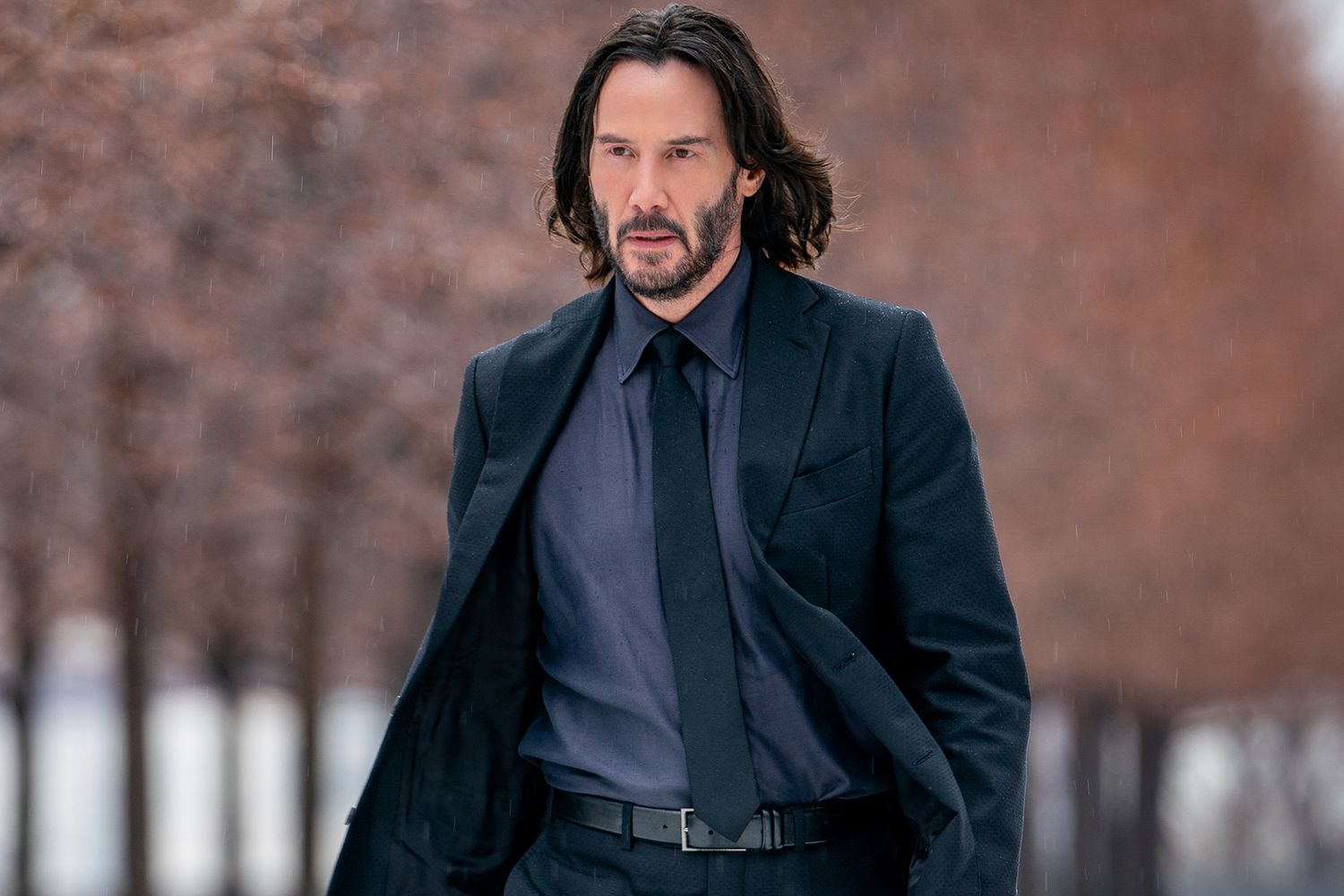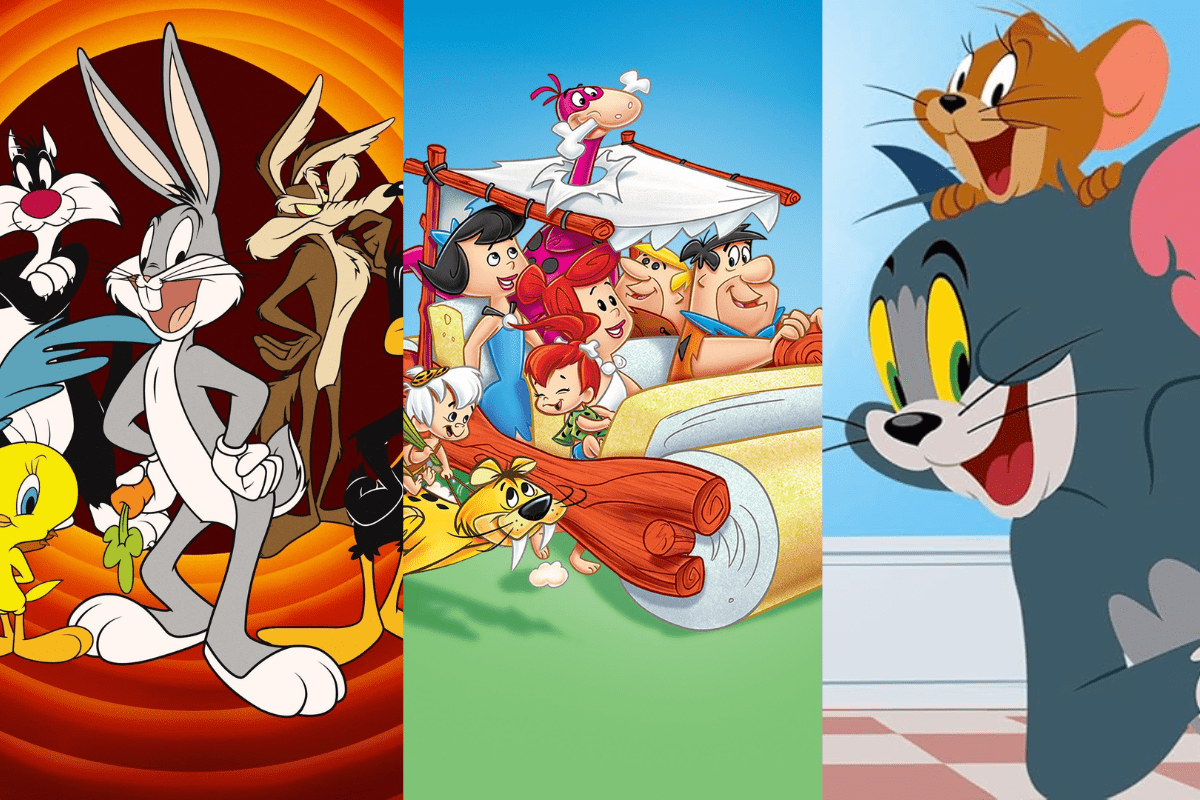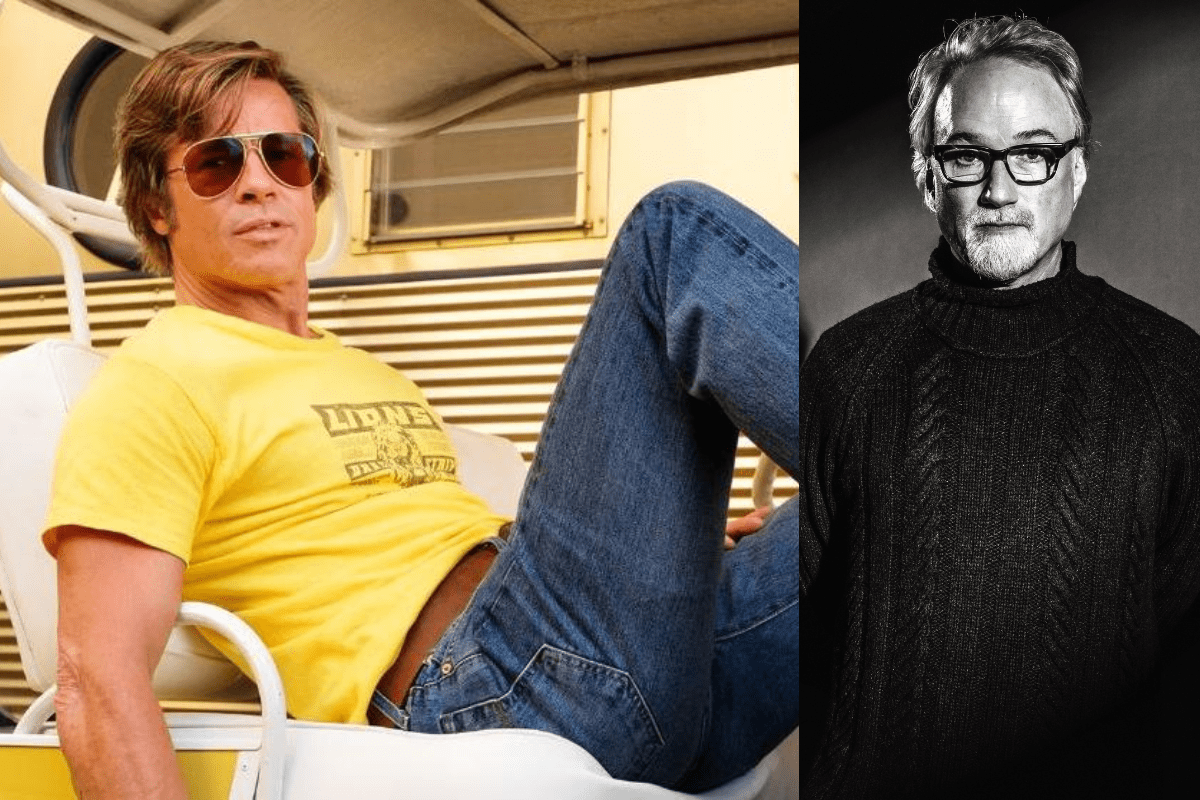Articolo pubblicato il 12 Aprile 2024 da Bruno Santini
Diretto da Rudi Rosenberg, La Pesca – Una storia Esselunga è uno spot pubblicitario che sta facendo tanto discutere per i suoi contenuti e che, nelle ultime settimane, ha coinvolto anche la classe politica italiana, con la Premier Giorgia Meloni prima e il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini poi che si sono esposti a favore della pubblicità. Ma per quale motivo si sono generate così tante polemiche a proposito di questo spot? Di seguito, è importante valutare tutto ciò che non funziona nella pubblicità in questione.
Di che cosa parla La Pesca, lo spot dell’Esselunga
Prima di addentrarsi nell’analisi di quelli che sono gli errori di La Pesca, lo spot diretto da Rudi Rosenberg per Esselunga, è importante specificare brevemente di che cosa parla: all’interno della pubblicità ci si trova in un supermercato dove una bambina si allontana da sua madre per prendere una pesca. La madre, nervosa per l’atteggiamento di sua figlia, decide di accontentarla: si scopre che la pesca è stata voluta dalla bambina per tentare di riavvicinare i suoi genitori, separati. Appena vede suo padre, infatti, la protagonista dello sport gli dice che la pesca è un regalo della madre; il padre, emozionato, risponde a sua figlia che la chiamerà per ringraziarla.
Tutti gli errori comunicativi presenti nello spot di Rudi Rosenberg
“Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli.”, diceva Oscar Wilde in una famosa citazione che si è soliti condividere, soprattutto in ambienti social, a proposito di fenomeni mediatici che diventano oggetto di grande attenzione, spesso a seguito di una polemica o per connotazioni negative. Ma si tratta davvero di una verità? Lo spot dell’Esselunga poggia su una base comunicativa piuttosto attempata che, a dire il vero, non è così lontana dalla portata mediatica italiana sovente applicata a diversi ambienti, specie quello dei new media: stimolare dei trigger nel fruitore del messaggio, affinché quest’ultimo possa ricordarsene. La stimolazione della memoria mediatica è un tema oggetto di costante attenzione da parte degli studi di marketing che – come per tante altre materie che hanno, come oggetto di interesse, l’umano e le sue caratteristiche nella socialità – tendono ad evolversi anno dopo anno.
I moderni studi di neuromarketing dimostrano che no, non è vero che l’unico fattore di interesse è la diffusione di un messaggio; l’esigenza primaria da parte di numerose e moderne realtà mediatiche è volto verso una personalizzazione spasmodica del contenuto pubblicitario, affinché possa generare un responso emotivamente positivo nello spettatore: in altre e più semplici parole, stimolare un trigger è sì importante, purché questo venga associato ad una stimolazione sensoriale positiva. Indipendentemente dal gusto e dal piacere soggettivo, la pubblicità dell’Esselunga associa il suo messaggio mediatico ad una serie di elementi emotivamente negativi: il distacco, l’abbandono, la tristezza, il senso di colpa e la cattiveria, nella rappresentazione di uno dei due genitori osservato nella sua porzione di severità, l’altro in uno stato di vittima. In due minuti di spot, non esiste neanche un messaggio, elemento o immagine che possa essere associato ad alcune idee chiave delle moderne ricerche di neuromarketing, quali gioia, eccitazione, sorpresa o nostalgia, quest’ultima intesa nella sua accezione di mancanza positiva.
Attenzione, però, a non travisare la precedente asserzione: non si sostiene che le pubblicità debbano essere necessariamente felici o stimolare una risposta positiva dello spettatore, bensì che i contesti debbano essere tra loro coerenti. Per essere maggiormente chiari, infatti, nessuno si aspetterebbe da uno spot di Save the Children o Unicef dei bambini festosi e allegri, per quanto moderne sperimentazioni del messaggio di queste società sono volte ad un’ibridazione degli elementi (ad esempio, si osservano sempre più bambini che sorridono, nonostante la tragedia), comprendendo il potenziale della risposta mnemonicamente positiva del fruitore; il supermercato è un ambiente comunemente associato all’idea di condivisione familiare e di compostezza del nucleo, per cui – per quanto si possa pensare ad una scelta di controtendenza voluta, ovvero lo sfasciare quell’idea convenzionalmente data del luogo in cui si cammina tra le corsie con mamma e papà – il messaggio è semplicemente sbagliato nella sua dimensione concretamente comunicativa.
La famosa pesca, oggetto di costante scherno e polemica a seguito della diffusione della pubblicità, è anch’essa un errore comunicativo, probabilmente ancor più potente rispetto alla natura emotiva del messaggio: è, in effetti, un elemento che nella fruizione mediatica è già forte, dati degli antecedenti di cui il cinema abbonda (Chiamami col tuo nome e Parasite, per citarne alcuni), ma ciò non basta: anzi, è paradossalmente un difetto; ne sovviene anche in questo caso un’idea vetusta della comunicazione: non basta associare il proprio elemento a un’immagine insita nella memoria collettiva, dal momento che la stimolazione sensoriale necessita di pilastri emotivi, contestuali e sociali. Se guardare una pubblicità dell’Esselunga in cui l’oggetto protagonista della narrazione viene accostato, anche con scherno, all’oggetto sessuale di un altro film, c’è un errore di fondo. Si potrebbe discutere, in ultimo, anche dell’idea simbolica dell’oggetto che – nei fatti – dovrebbe rappresentare la comunione tra due persone: la storia letteraria e artistica vede, nel frutto tondo (a partire dall’Iliade), una base di discordia, non certamente di avvicinamento. Per cui, a meno che l’idea dello spot non sia sovvertire ogni immagine interiorizzata dallo spettatore fin da quando ne ha memoria – un compito a dire il vero assai arduo -, ciò che si osserva è nient’altro che grossolanità.
Il tema della separazione e la superficialità di La Pesca
Si viene adesso ad una questione che esula rispetto allo sguardo analitico e prettamente comunicativo: che cos’ha di sbagliato La Pesca relativamente al suo messaggio? Semplicemente, non è attuale. Propone un’idea di separazione, di lontananza e di approccio emotivo a queste ultime grezzo, per certi versi infantile e poco proficuo. Trattare il divorzio o la separazione rendendo una delle due parti severa e colpevole (la donna) e una bonaria e vittima (l’uomo) non è solo un enorme e violentissimo passo indietro rispetto a ciò che la cultura mediatica dovrebbe, per prima, insegnare al suo spettatore, ma anche una semplificazione tremenda di ciò che una vicenda difficile porta con sé. La Pesca sembra uno spot nato dalla superficialità e dalla semplificazione: si direbbe che la durata influisce e che non c’è tempo di raccontare una storia in due minuti, ma ci si potrebbe facilmente opporre sostenendo che il cinema è pieno, fonda anzi la sua storia, di cortometraggi che durano anche meno, sapendo raccontare molto più e meglio.
Ciò che deriva dalla visione di tale spot è la mancanza di visione globale, una lontananza dalla realtà sociale che non si riesce a toccare con mano, oltre che una certa pigrizia nel rappresentare dinamiche che necessitano di attenzione e sforzo: ancora una volta, non basta semplicemente affermare un concetto, evocare un’immagine o diffondere un messaggio per renderlo funzionale al proprio scopo. Uno spot di questo genere offende tutte le parti, bambini compresi, che non hanno certamente il dovere di comprendere la vita nelle sue difficoltà, alla loro età, ma che hanno il diritto di non essere mai offesi nella loro intelligenza.