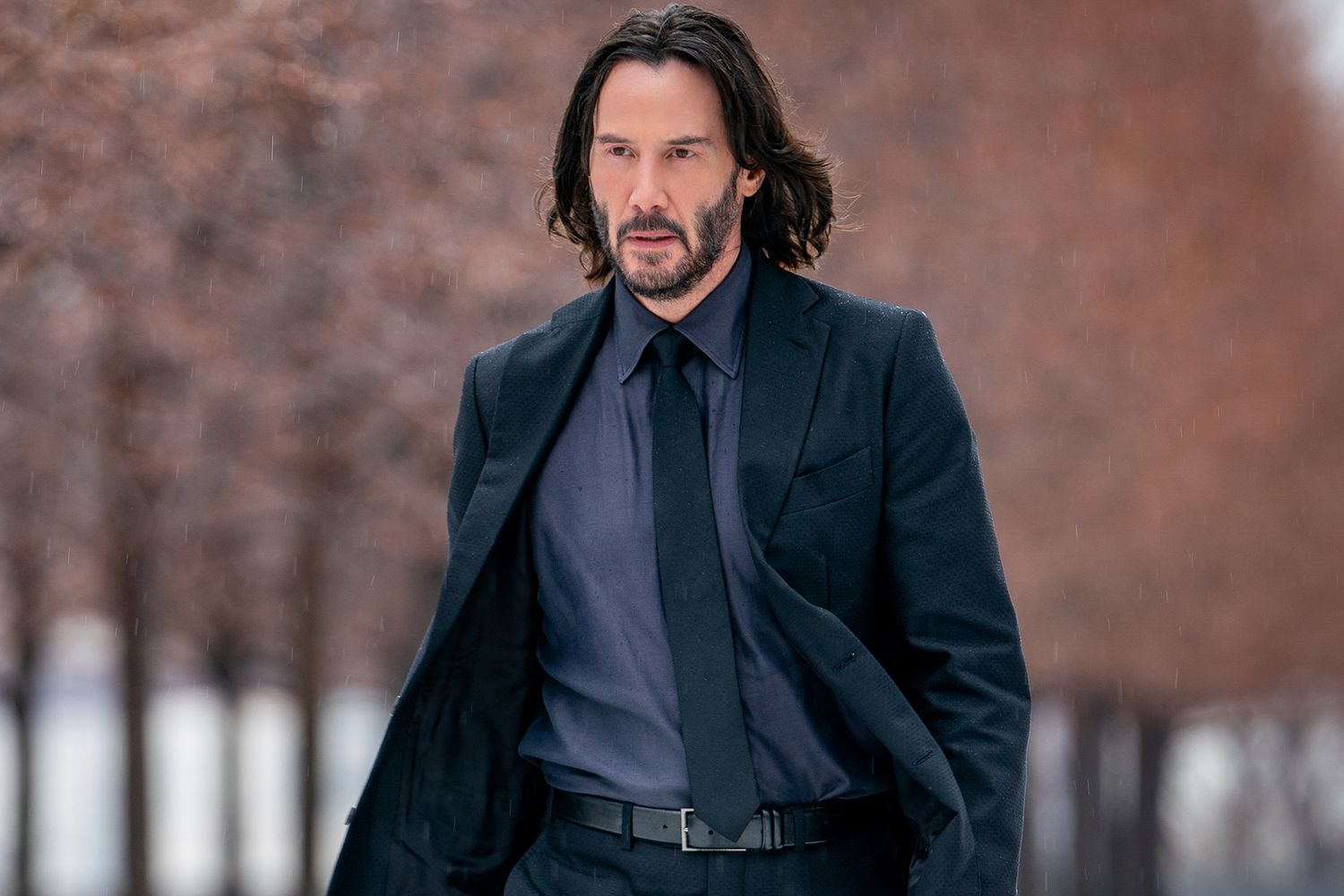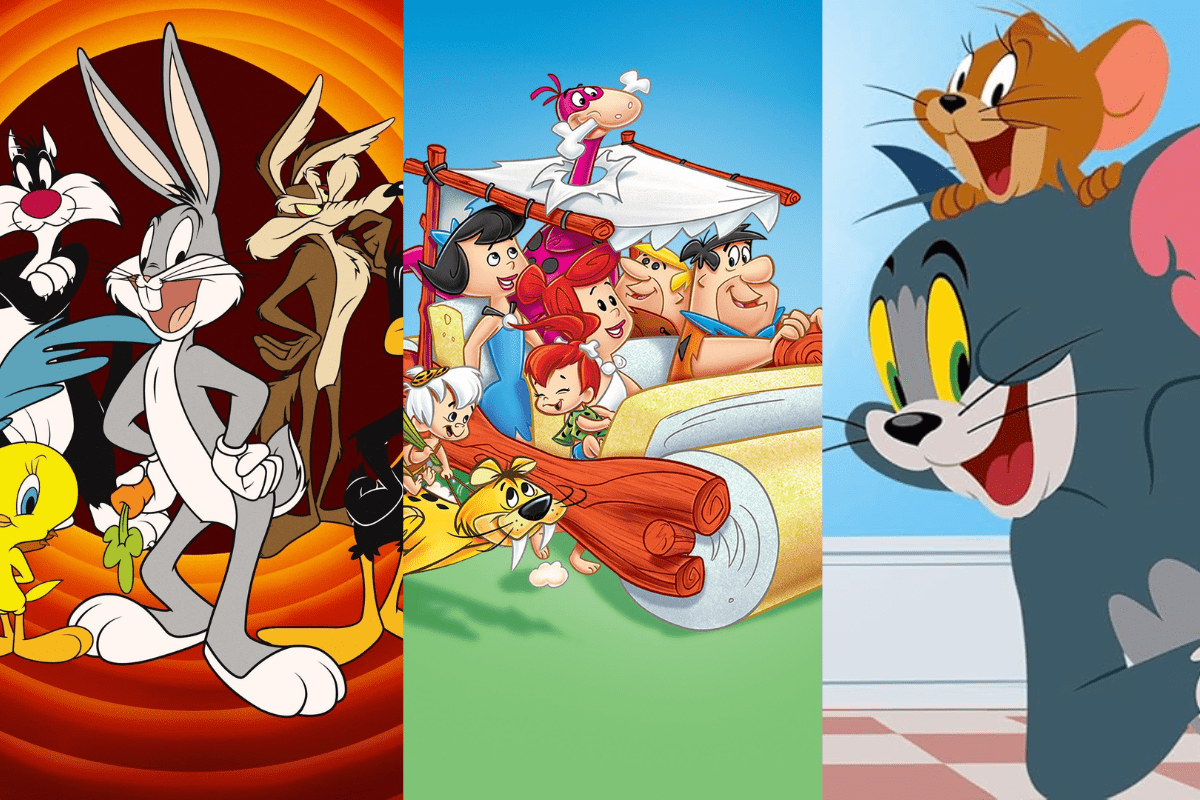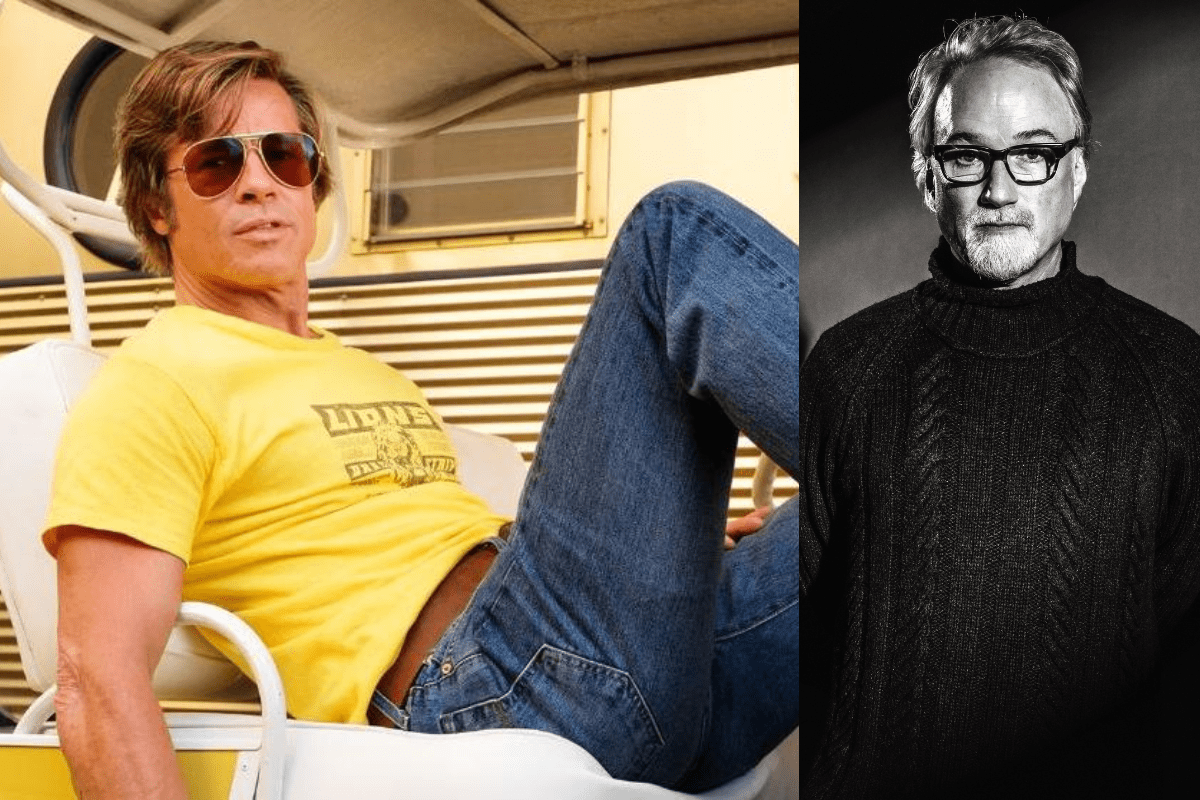Articolo pubblicato il 27 Ottobre 2024 da Bruno Santini
Il decimo film di Paolo Sorrentino, Parthenope, è probabilmente uno dei più divisivi della sua filmografia. Dopo aver firmato un vero e proprio trattato autobiografico con È stata la mano di Dio, il regista partenopeo ha mantenuto un saldo legame con la città di Napoli, trattandola come sfondo di vicende che sono legate ad una serie di temi e ragionamenti sicuramente molto importanti. Parthenope è un film che ha fatto molto discutere e che, allo stesso tempo, ha generato anche delle polemiche in virtù di alcune scelte e di diverse frasi di cui ci si serve all’interno del film, nascondendo un forte e profondo significato. Ma qual è, per l’appunto, il significato di Parthenope di Paolo Sorrentino? Per comprenderlo, è importante ragionare su alcuni dei temi che campeggiano all’interno del decimo lungometraggio dell’autore.
I temi di Parthenope di Paolo Sorrentino e il trattamento della gioventù
Al fine di sottolineare quale sia il significato di Parthenope di Paolo Sorrentino, è molto importante procedere con una valutazione di quei temi che sono trattati all’interno del film del regista napoletano e, su tutti, non si può fare a meno di notare quanto quello della giovinezza sia fortissimo e costante nella sua valutazione da parte del regista napoletano. La crescita di Fabietto (quindi di Sorrentino stesso) era stata una costante di È stata la mano di Dio, dove l’autobiografia incontrava il racconto in un film complessivamente molto personale e intimo da parte del regista.
In Parthenope, invece, ci si affaccia al racconto di una personalità che da Sorrentino è potenzialmente molto distante, raccontando piuttosto una sorta di storia autobiograficamente impossibile: quella di una giovane donna negli anni ’70 che Sorrentino, ovviamente, non è stato. La gioventù è delineata all’interno di tutto il film, attraverso un procedere che sottolinea gli attimi della vita di Parthenope: una figura eterea, quasi sfumata, che esiste a metà tra il mito e la verità, essendo non del tutto donna e non concretamente quella sirena da cui riprende il nome; l’analisi di Paolo Sorrentino permette di evidenziare il significato di Parthenope nei suoi rapporti, nelle sue scelte e nelle sue rinunce: quella rappresentata è una vita come le altre, o forse una vita che non si è compiuta del tutto e che vive di rimpianti e scelte che non hanno davvero valore (è emblematica, allora, la reiterazione della canzone “era già tutto previsto”).
Nel significato di Parthenope si osservano tutti quei temi cari al regista: la magia nella rappresentazione del mondo, la disillusione che si compone attraverso sagace ironia e quella costante invettiva (contro la chiesa, i miti, le religioni ma anche contro la pochezza degli esseri umani) che si ritrova soprattutto nelle frasi del film. Parthenope, allora, è un mezzo per raccontare non soltanto una vita che sarebbe potuta essere – e che Sorrentino non ha vissuto, a differenza di È stata la mano di Dio -, ma anche un qualcosa che garantisce il delinearsi di un ragionamento sulla città e su Napoli, la reale protagonista del film.
Il trattamento della città di Napoli in Parthenope di Paolo Sorrentino
Napul è mille culure, diceva Pino Daniele all’interno di una delle canzoni più celebri e rappresentative della cultura musicale e artistica italiana. Il regista napoletano ha scelto di inserirla come canzone finale di È stata la mano di Dio, film che racconta non soltanto la sua vita ma anche il suo rapporto con la città di Napoli: ormai, in questo ideale dittico, è proprio la città che diventa protagonista della narrazione del regista, oltre i personaggi e le vicende.
Per questo motivo, nel ricercare il significato di Parthenope di Paolo Sorrentino, è importante sottolineare che Napoli ne fa parte, essendo una vera e propria componente integrante del racconto, e non soltanto una cornice di quanto si osserva. Come cantava Pino Daniele, la città di Napoli è ricca di difetti che vengono sottolineati anche all’interno del film, tramite il personaggio di Greta Cool prima e di Parthenope stessa poi; sono pensieri, questi, che appartengono allo stesso regista e che non appaiono nuovi nella storia dell’arte (basti pensare a quanto Peppino De Filippo ritenesse i napoletani ipocriti nella loro falsa gioia), ma che non nascondono quella bellezza della città di Napoli che rivive, quasi pulsante, in ogni momento. Ecco che, allora, la fine del film è dissacrante: “E comunque Dio non ama il mare, ricordatevelo” dice una voce di sottofondo, che sfata un ennesimo mito sulla città di Napoli così come l’intero film si preoccupa di fare, spogliando di sacralità ogni discorso che venga realizzato sulla città e mettendo in primo piano tutti i suoi enormi problemi, pur comunque non cancellando o negando mai il suo alone di magia.