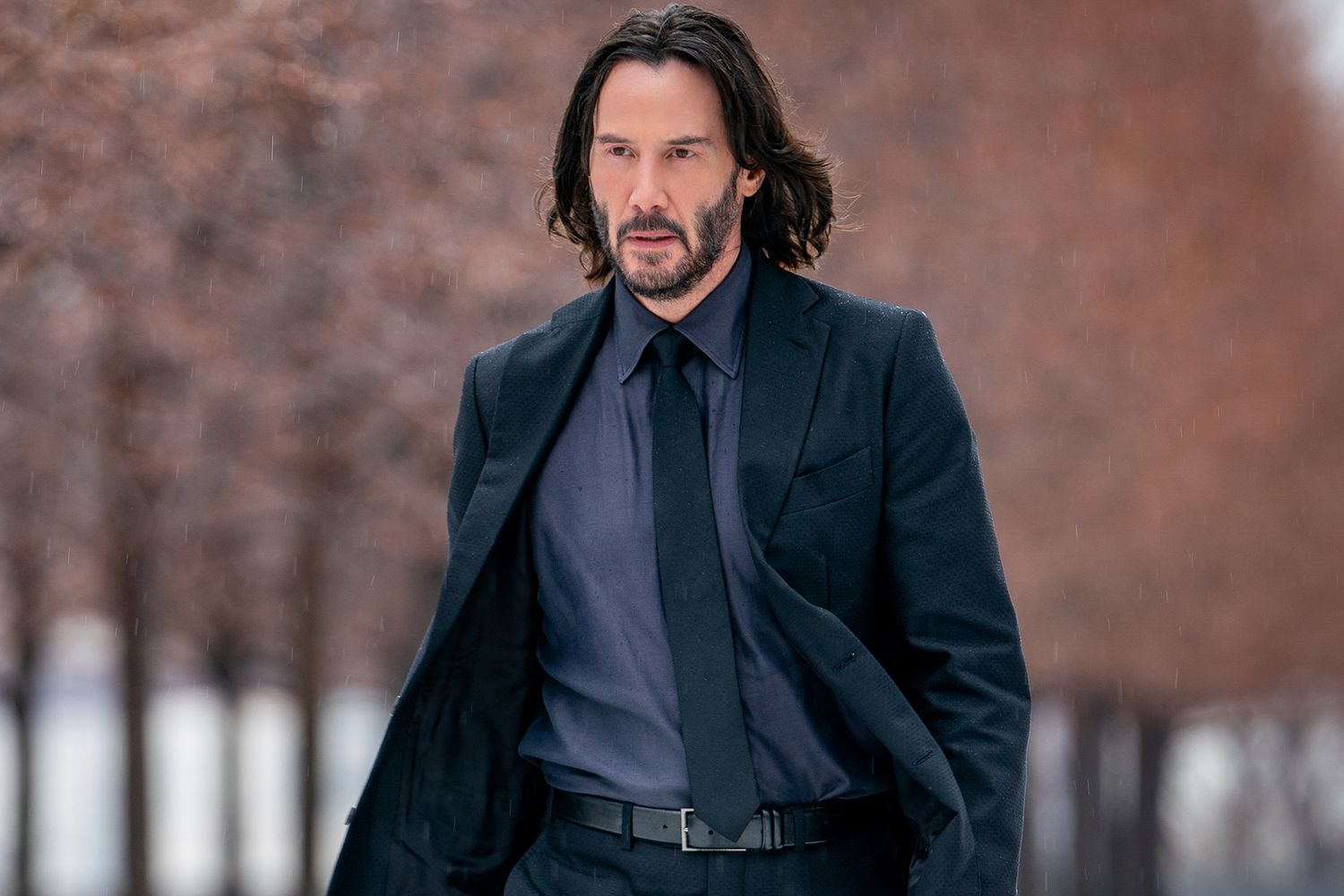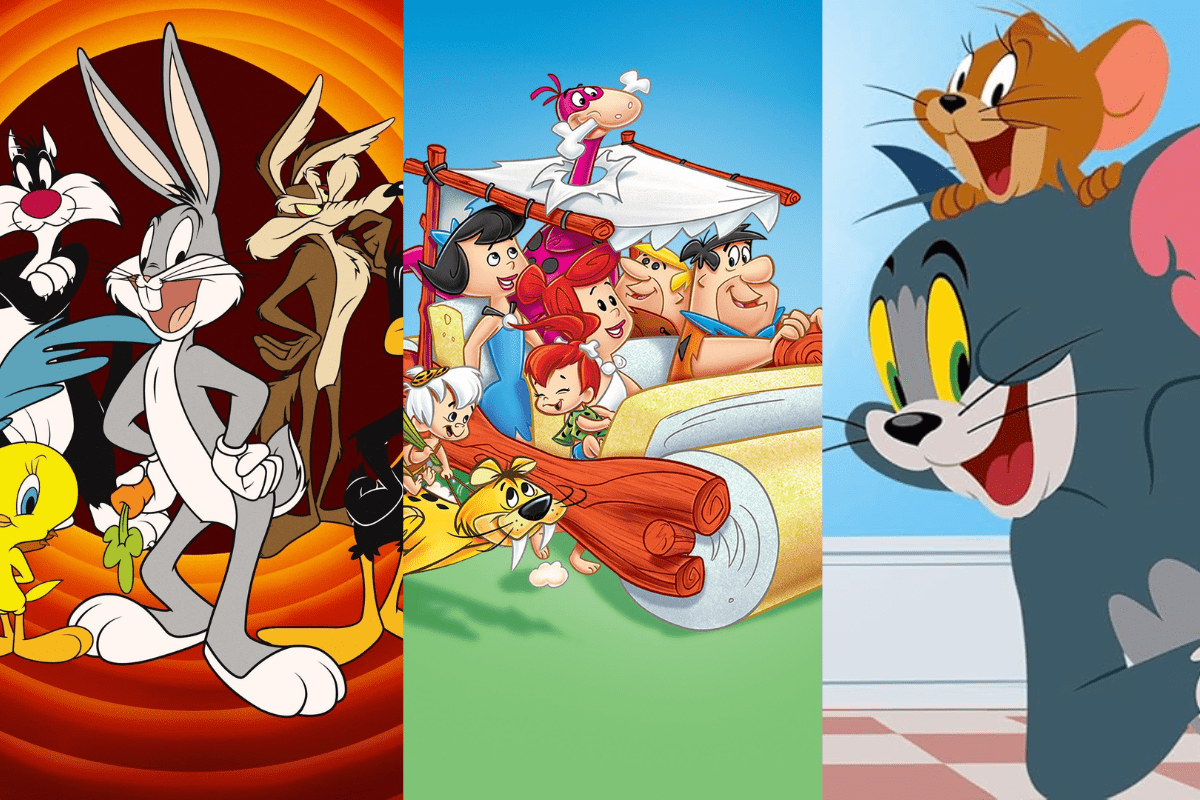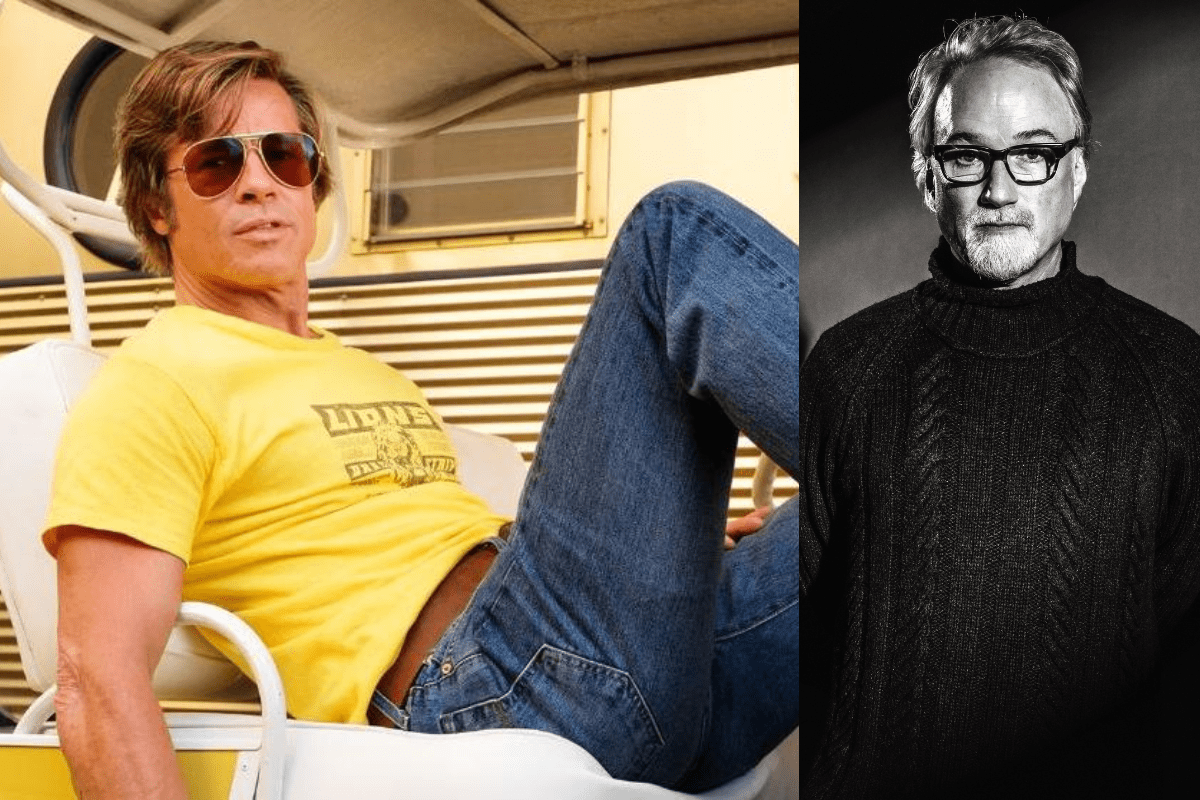Articolo pubblicato il 6 Novembre 2024 da Bruno Santini
Film che abbiamo compreso essere evidentemente molto complesso, soprattutto per tutte le allegorie e le significazioni che presenta, Parthenope è un lungometraggio che può essere colto completamente solo ad uno sguardo successivo rispetto al primo. Allo stesso tempo, è molto importante tentare di ricordare quali possano essere alcuni dei dettagli presenti all’interno del film, i quali offrono una chiave di lettura differente al lungometraggio stesso; se comprendere il significato del figlio di Devoto Marotta è certamente importante, allo stesso modo lo è anche approcciare ai nomi presenti nel film in questione. Ognuno di questi, infatti, racconta una storia e richiama la tradizione storica della città di Napoli: ma qual è il significato dei nomi?
Parthenope
Si parte, nel definire il significato dei nomi in Parthenope di Paolo Sorrentino, con quello della protagonista Parthenope, che richiama il mito della celebre nascita della città di Napoli e che assume una portata simbolica sicuramente considerevole. Ad essa è legata una grandissima tradizione leggendaria ma, secondo la più accreditata, Parthenope era una delle sirene che tentarono di attrarre Ulisse con il loro canto: di fronte al rigetto di lui, che aveva deciso di ascoltarlo ma di farsi legare alla nave, Parthenope si gettò in mare trovando la morte e, dal suo corpo, nacque poi la terra che diventerà Napoli. Il film dialoga costantemente con l’aspetto leggendario, pur tentando allo stesso tempo di smitizzare l’insieme di quei racconti che vengono offerti in tal senso, attraverso un certo cinismo che definisce tutte le figure.
Raimondo Di Sangro
In due punti del film, che corrispondono alla carriera universitaria di Parthenope, si conosce anche il suo cognome: Di Sangro. Ciò permette di comprendere che suo fratello si chiami Raimondo Di Sangro, un nome che ha un significato sicuramente molto importante all’interno del film; conosciuto come Il Principe, Raimondo Di Sangro è stato inventore, esoterista, militare, alchimista, massone, accademico e letterato italiano, grazie ad una personalità costantemente eclettica che gli ha permesso di diventare uno dei simboli della città di Napoli: in effetti, Il Principe è conosciuto per essere stato il committente dell’ampliamento della cappella Sansevero, che fu da lui arricchita con statue barocche e, soprattutto, con il celebre Cristo velato.
Tutto ciò appartiene certamente alla dimensione della Napoli leggendaria, che si abbandona al fascino del culto e del mistero, con la cappella Sansevero che conserva ancora oggi i misteri di una tradizione alchemica che – secondo diverse visioni – sarebbe stata alla base delle creazioni che si trovano al suo interno. Allo stesso tempo, però, indica anche il fascino della committenza, di chi si ritrova abbacinato dal candore di Napoli tanto da subirne totalmente l’investitura che, in effetti, nel film porta Raimondo a scegliere il suicidio.
Devoto Marotta
Se con il nome di Raimondo Di Sangro di sicuro si incontra un personaggio molto importante nella cultura e nella storia di Napoli, anche con Devoto Marotta Paolo Sorrentino costruisce un personaggio sicuramente molto importante, fin dal suo nome. Il riferimento, con “devoto” che appare qui nelle vesti di aggettivo, è sicuramente a Giuseppe Marotta, scrittore, sceneggiatore e paroliere italiano nato e morto a Napoli. Tra i suoi lavori più importanti, anche in ambito cinematografico, ci sono i soggetti per Soltanto un bacio, Amor non ho… però… però, La macchina ammazzacattivi, Tempi nostri – Zibaldone n. 2 e L’oro di Napoli, con la regia di Vittorio De Sica e basato sull’omonima raccolta di racconti, realizzati inizialmente per Il Corriere della Sera, in cui Marotta racconta la storia di personaggi che vivono la propria storia sullo sfondo della città di Napoli.
Un contributo letterario sicuramente molto importante, per una Napoli che si racconta che ricerca la testimonianza – anche cinica – di un autore: l’antropologo Devoto Marotta è colui che finalmente può vedere al riparo da tutto ciò che filtrerebbe il suo sguardo, così come Giuseppe Marotta ha saputo lucidamente offrire un saggio della storia di Napoli.
Roberto Criscuolo
Altro personaggio sicuramente molto importante, nel film Parthenope di Paolo Sorrentino, è quello di Roberto Criscuolo. Colui che porta la protagonista del film a conoscere la realtà dei bassifondi napoletani, là dove si consuma il rituale della fusione, con le due famiglie rivali che si uniscono grazie ad una futura nascita: il personaggio è certamente rappresentativo, ma il suo nome assume un significato tutt’altro che banale nel film di Paolo Sorrentino. Criscuolo è il cognome di uno dei membri più importanti del clan Misso, tra i più celebri e importanti nel contesto del Rione Sanità: al di là di questo riferimento – non necessariamente diretto, trattandosi comunque di uno dei cognomi più diffusi nella città di Napoli – appare chiara la volontà di mostrare una Napoli che si abbandona al fascino della camorra in tempi bui della propria storia, sia per bisogno che per volontà concreta.
Tesorone
L’ultimo tra i nomi del film di Paolo Sorrentino che meritano di essere spiegati è sicuramente quello di Tesorone che, tra tutti, appare sicuramente il più semplice; antonomasia vera e propria, che indica il legame della città con il miracolo di San Gennaro, Tesorone è colui che custodisce il Tesoro del Santo, che poi si concede alla bellezza della protagonista. Nel suo costante tentativo di spogliare e rivestire la città di Napoli del mito, Paolo Sorrentino realizza una delle scene più forti di tutto il film, con il sangue di San Gennaro che si scioglie nel momento dell’orgasmo e con la folla che, di fronte all’assenza di miracolo, è indotta a credere a qualsiasi “falso idolo”, con il sangue del mestruo che diventa quasi la testimonianza su un corpo del miracolo di San Gennaro.