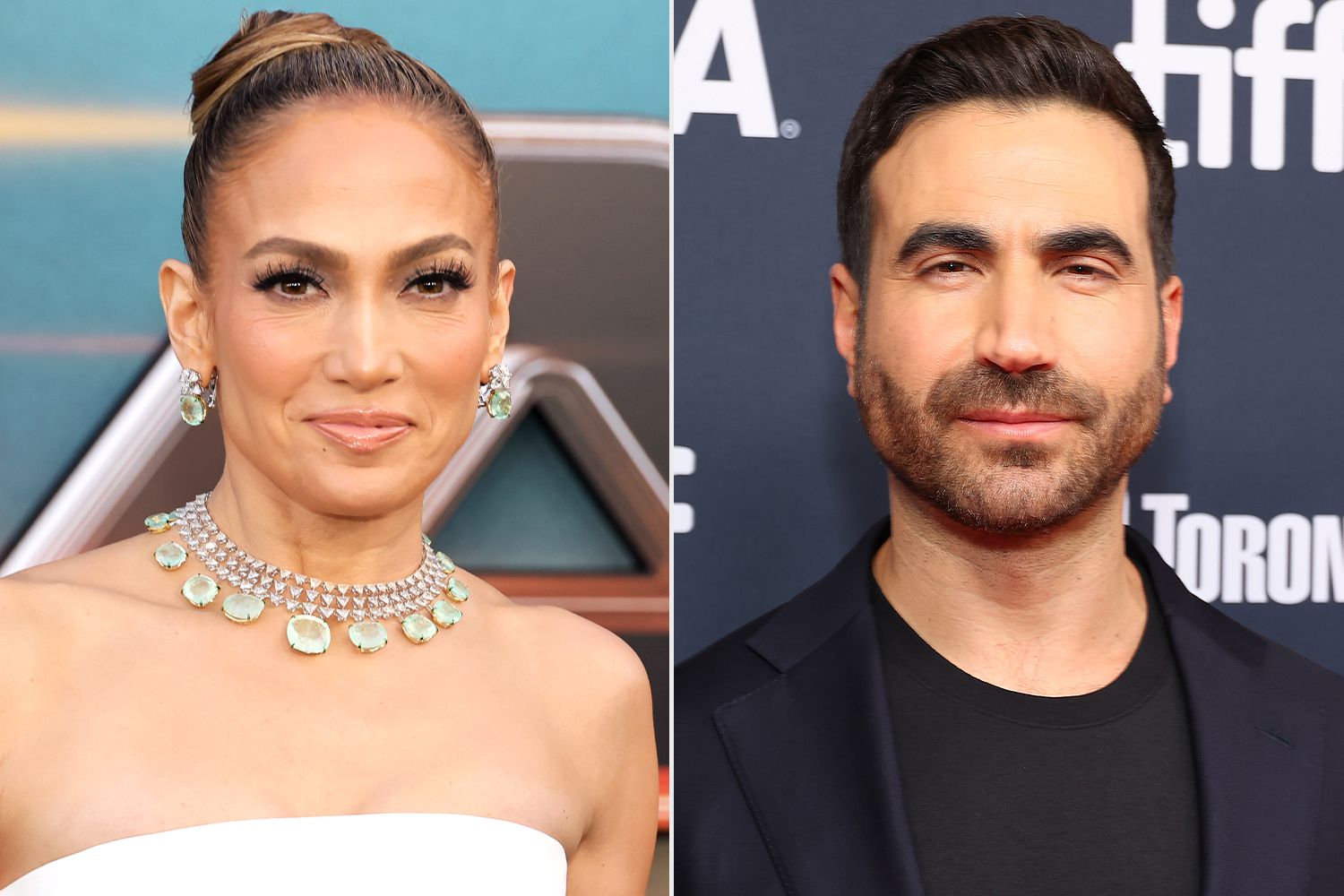Roberto De Feo aveva colpito molto con il suo “The Nest”, il quale voleva cercare di essere un horror atipico per gli standard a cui siamo abituati per le opere rivolte al grande pubblico, differenziandosi da determinati film italiani. Dopo che il primo film ha venduto bene ed ha avuto una buona accoglienza critica, Netflix ha deciso di puntare su questo talento e di distribuire il suo film successivo, “A Classic Horror Story”, stavolta scritto e diretto insieme a Paolo Strippoli.
Il film parla di due ragazze, due ragazzi ed un uomo quarantenne che guidano un camper per raggiungere una meta comune a tutti loro. Tuttavia, durante il tragitto, il camper deraglierà in un incidente, finendo in un posto isolato dei boschi, vicino ad una casa molto sinistra. I protagonisti non riescono a trovare una strada di casa e dovranno sbrigarsi, perché sembra che in quel posto ci siano delle misteriose figure legate a delle leggende del posto e che sono intenzionate a fare dei sacrifici umani.
Dal punto di vista registico, ancora una volta abbiamo profondo senso di claustrofobia che comprime l’intrappolamento da una situazione senza via d’uscita, ancora più forte di quello che c’era in “The Nest” (che doveva infatti avere anche un’apparente tranquillità). Le inquadrature geometriche sono perfette, così come dettagli sulla fisicità dei personaggi continuamente compatta dalle ferite delle proprie azioni, senza però andare mai sullo splatter puro, ma facendo comunque avvertire allo spettatore ogni singolo dolore. La fotografia di Emanuele Pasquet è perfetta, con dei richiami a “Suspiria” di Dario Argento che però si mischiano alla sporcizia di opere come “Non Aprite Quella Porta” e di “La Casa”, come per dare un senso realistico alla cosa che però è sempre accompagnata da elementi di eleganza (e che si sposeranno con un concetto del film che verrà fuori più avanti). Le musiche sono di profondo impatto e gli attori abbastanza in parte, specialmente Matilda Lutz che è sempre molto capace e carismatica.
La struttura di questa determinata opera funziona bene nell’inquietudine del mistero, dato che lo stesso luogo in cui i protagonisti vengono intrappolati sembra davvero una zona al di fuori della civiltà odierna, in cui sembra essere tornati indietro nel tempo perché la leggenda della propria terra vuole di nuovo far scorrere il sangue, unico modo in cui l’essere umano ha imparato a cibarsi per far si che il proprio strato sociale possa continuare a mandare avanti la civiltà: gli uomini che diventano cani, mentre gli altri uomini finiscono per essere cibo. Non importa se sei un essere umano, per il resto del mondo sei solo carne da macello. Questo concetto non solo ricorda il grande “Midsommar” (che gli autori omaggiano anche visivamente), ma si mischia anche ad una distruzione politica che denuncia quelle angherie di terrore che continuano a contaminare la bellezza apparentemente oscura delle nostre terre, qui portata all’estremo.
Ma il tocco più interessante dell’opera è la metacinematografia: il film infatti attacca, attraverso soluzioni visive e narrative ingeniose ed anche divertenti, la totale mancanza di comprensione dello spettatore medio italiano, criticandone l’approccio nei confronti delle opere di genere prodotte da noi, in cui si pretende qualità ma con sterilità. Il senso infatti è il criticare sempre il proprio paese perché si osa poco, ma allo stesso tempo siamo sempre pronti a dire a prescindere che noi italiani non siamo capaci di fare cinema di genere all’altezza di quello estero, decidendo di bocciare l’opera ancora prima di vederla. Questo approccio non è solo un attacco alla superficialità italiana artistica, ma si fonde anche con la mancanza di empatia dell’Italia nei confronti delle persone, che per questo impedisce il nostro paese di fare qualunque salto che non è solo legato alla cinematografia, ma a tutta la nostra società condannata a distruggersi per il proprio egoismo e per il proprio desiderio di ottenere risultati a discapito da tutti.
E nonostante “A Classic Horror Story” attacchi lo spettatore medio, l’opera è realizzata affinché anche questa fetta di pubblico riesca perfettamente a rimanere in tensione, con la costante paura della rabbia che può venire a trovare, mentre ogni urla, ogni singola ferita che sgretola il corpo umano dissezionato dalle “divinità” adorate nei culti, è sempre più avvertibile in ogni frame anche solo con il suono. Un’opera che riesce a reggere il confronto con gli horror internazionali, che intrattiene benissimo, ma che allo stesso tempo riesce a prendersi i propri spazi per rimarcare una mano d’autore che vuole trasmettere anche molto altro. “A Classic Horror Story” è un’altra prova che dimostra che noi italiani possiamo ancora fare dell’ottimo cinema horror… e molto altro.
Andrea Barone