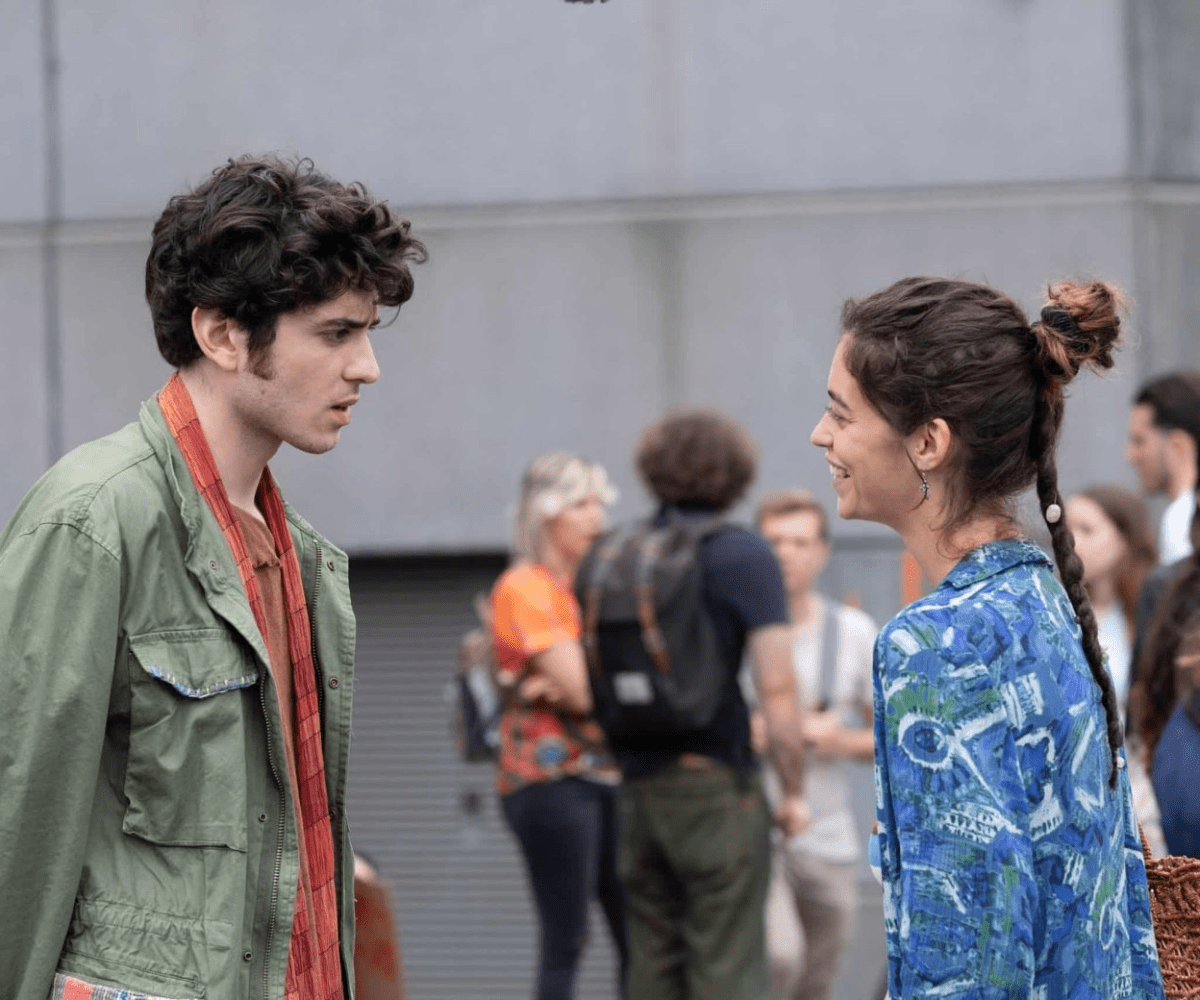Articolo pubblicato il 24 Novembre 2024 da Giovanni Urgnani
Distribuito negli Stati Uniti direttamente sulla piattaforma digitale Max, a partire dal 10 settembre 2024, mentre in Italia nelle sale cinematografiche come evento speciale nei giorni 25-26-27 novembre dello stesso anno, grazie alla distribuzione di Lucky Red. A testimoniare il processo creativo della realizzazione dell’ultimo film d’animazione dello Studio Ghibli Il ragazzo e l’airone (2023) è stato ingaggiato il regista Kaku Arakawa, già autore del celebre Never-Ending Man: Hayao Miyazaki (2016). Ma qual è il risultato di Hayao Miyazaki e l’airone? Di seguito la sinossi ufficiale e la recensione del film.
La sinossi di Hayao Miyazaki e l’airone, presentato a Cannes 77
Presentato in anteprima mondiale alla settantasettesima edizione del Festival di Cannes, in occasione della consegna della Palma d’oro onoraria allo Studio Ghibli. Ma di cosa parla Hayao Miyazaki e l’airone? Di seguito la sinossi ufficiale del documentario diretto da Kaku Arakawa:
“Girato durante i sette anni di lavorazione de Il ragazzo e l’airone, il documentario è un viaggio esclusivo nel processo produttivo e creativo dello Studio Ghibli e un’immersione nella storica collaborazione di Miyazaki con il produttore Toshio Suzuki, una sorta di danza tra inganni e amicizia, che rispecchia quella di Mahito e l’airone, con Suzuki che stimola Miyazaki a spingersi sempre più in là nella sua creatività, arrivando alla creazione di un capolavoro senza precedenti.“

La recensione di Hayao Miyazaki e l’airone, di Kaku Arakawa
La scena finale di qualsiasi prodotto audiovisivo può essere determinante nel decidere l’approvazione o meno dello spettatore, assume un’importanza cruciale perché è quella impressa nella mente quando esce dal cinema o si alza dal divano di casa, essendo la più fresca. Questa volta a rimanere in mente è l’inizio, quasi geniale la scelta di cominciare il documentario con una situazione privata, che all’apparenza pare essere solo un modo per partire con un po’ di umorismo. Il Maestro Hayao Miyazaki si sta rilassando nelle acque termali, è nudo, in compagnia del suo fedelissimo compagno d’avventure Toshio Suzuki, dalla vita in su rimane in superfice ma non basta per evitare la censura dei genitali.
Un’immagine perfetta per sintetizzare la natura di tutta l’operazione: un viaggio di sette anni, ripassando per l’annuncio del ritiro del 2013 per poi concludere con il bis alla scorsa edizione degli Academy Awards, in cui Il ragazzo e l’airone ha trionfato nella categoria “Miglior film d’animazione”. Raccontando passo dopo passo la realizzazione del film, si entra dentro l’uomo all’interno dell’artista, rispondendo alle seguenti domande: Che Miyazaki è quello che riprende a lavorare? Quale tappa sta percorrendo nel suo percorso? Con che stato d’animo affronta questa nuova sfida? Il regista cofondatore dello Studio Ghibli è un uomo che sta vivendo con un grosso peso sulle spalle, un fardello dal suo punto di vista quasi inspiegabile, cioè l’assistere alla morte dei suoi più cari amici e colleghi di una vita, ogni lutto è una ferita al cuore di una persona che si trova nel cruciale momento dell’esistenza in cui ci si guarda indietro per tirare le somme.
Dalla visione ne esce innanzitutto un lavoratore instancabile, incapace di concepire l’attesa della fine a braccia incrociate. Partendo dal concetto che nell’Aldilà non si fa arte, ogni secondo deve necessariamente speso per creare nuovi mondi e nuovi personaggi, in più il lavoro è la terapia perfetta per affrontare il dolore emotivo della vecchiaia o, meglio, per trasformarlo in energia così da continuare verso il traguardo. Tra le maggiori perdite umane e professionali che hanno segnato i protagonisti coinvolti c’è naturalmente quella di Isao Takahata, venuto a mancare il 5 aprile 2018, la cui presenza si fa sempre più “ingombrante”, sia tramite i ricordi, sia tramite vecchi contenuti documentaristici; per Miyazaki è stato tutto: un socio in affari, un amico, un fratello, un rivale, ed infine un’ispirazione da concretizzare su carta e poi su “pellicola”.
Ma allora cosa c’entra il discorso di Miyazaki nelle acque termali? L’essenza e il significato di questa testimonianza raccolta da Kaku Arakawa stanno proprio qui, nel ricordarsi che si è di fronte ad una verità sempre e comunque filtrata da un punto di vista, che vuole mostrare molto ma non tutto, qualcosa resta sempre sotto la superfice dell’acqua, qualcosa resta sempre censurato. L’artificio del montaggio è sfruttato in maniera sublime nelle sue possibilità: frenetico, accelerato e dinamico, in grado di fare da collante tra il cineasta stesso e le sue opere, inserite appositamente nei momenti giusti, al fine di far provare determinate emozioni al pubblico, ed indurlo a concepire precise interpretazioni. Non va mai dimenticato che l’essere umano ha sempre degli obiettivi da raggiungere, soprattutto bisogna rimanere consci di star avendo a che fare con artisti, e gli artisti, per loro stessa ammissione, sono dei gran bugiardi.